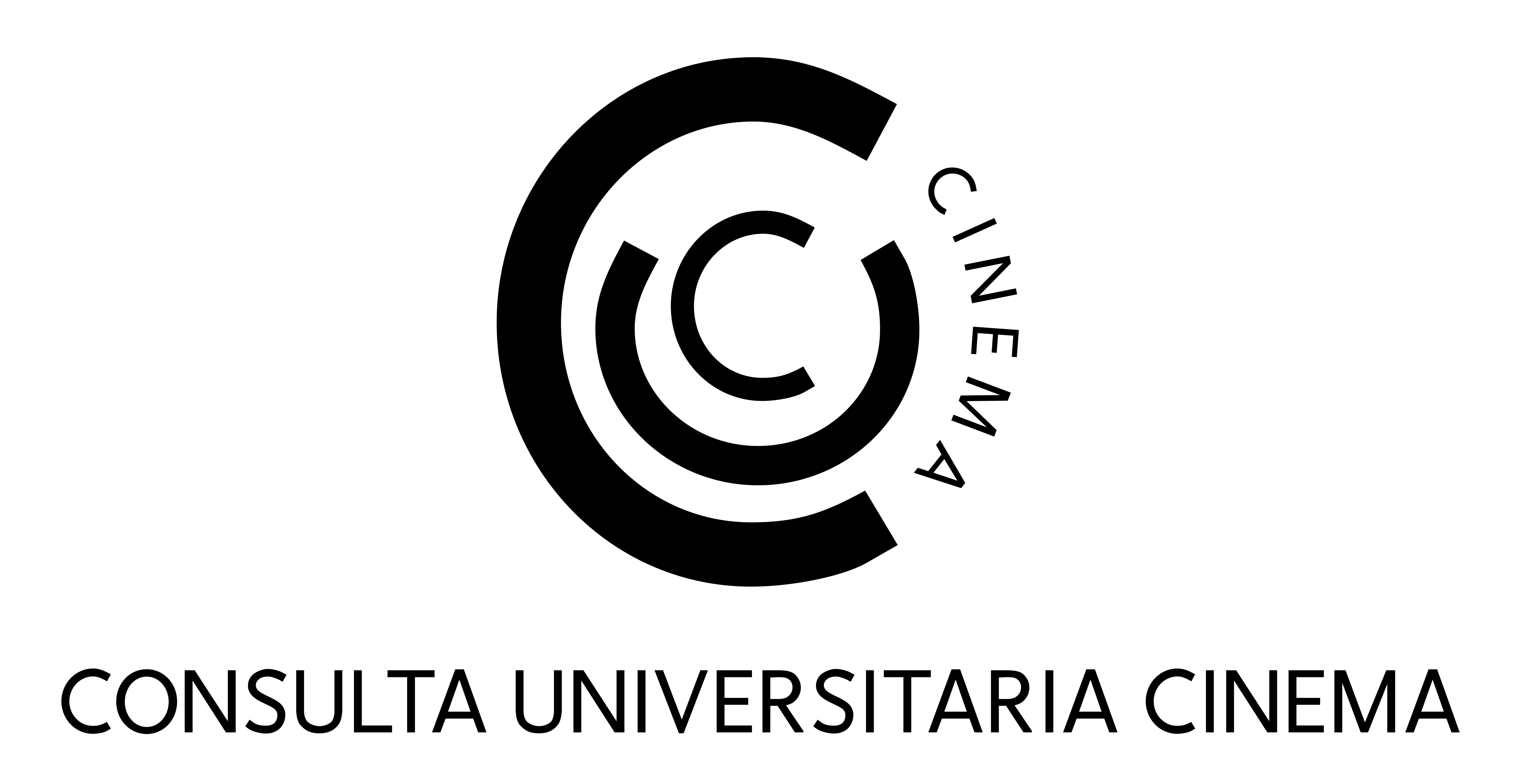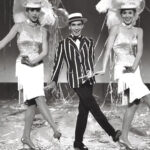Il Festival di Sanremo in numeri
Nel panorama degli ascolti televisivi italiani, il Festival di Sanremo rappresenta un unicum di straordinaria persistenza. Fatta eccezione per le partite di calcio in chiaro – soprattutto quelle che vedono coinvolta la nazionale italiana – nessuna tipologia di programma ha saputo attraversare i decenni e le epoche televisive mantenendosi su valori simili a quelli registrati dal Festival. Laddove generi come il varietà serale a cadenza settimanale o la fiction hanno gradualmente perso (nel primo caso) e guadagnato (nel secondo) centralità nei consumi degli italiani, l’appuntamento annuale con Sanremo rappresenta una costante inossidabile, forse la più rilevante dall’avvio delle misurazioni Auditel al termine del 1986. Basti pensare che nel corso delle 38 edizioni per cui disponiamo di dati d’ascolto verificati, dal 1987 al 2024, il Festival figura sistematicamente tra le dieci emissioni più seguite di ciascuna annualità, spesso spartendosi il podio con le fasi finali dei Mondiali o degli Europei di calcio. Considerando, per ciascuna edizione, solo la singola serata più seguita a livello di AMR (Average minute rating), si ricava un valore medio di 13.3 milioni di spettatori, corrispondente a poco meno del 60% degli individui complessivamente davanti alla TV e a circa un quarto della popolazione italiana con almeno 4 anni di età.
Una periodizzazione del Festival secondo gli ascolti
Naturalmente, i valori medi calcolati su un arco temporale così prolungato nascondono oscillazioni annuali anche forti, legate tanto all’evoluzione della manifestazione nel tempo, quanto alla riconfigurazione del contesto mediale italiano. In un’ipotetica periodizzazione fondata sui dati di consumo, potremmo individuare l’età dell’oro di Sanremo nel frangente che va dal 1987 al 2000: in 14 edizioni la serata più seguita si attesta solo due volte al di sotto dei 15 milioni di telespettatori – superando, invece, i 17 milioni in tre edizioni – mentre il dato di share non scende mai sotto il 55%.
A partire dall’edizione del 2001, condotta da Raffaella Carrà, gli ascolti di Sanremo subiscono un primo ridimensionamento, che si concretizza in un periodo particolarmente critico tra il 2003 e il 2008, coincidente, peraltro, con una lieve contrazione dell’intera platea televisiva in prime time, prima di una nuova fase di crescita trainata dallo switch off del segnale analogico. Con l’eccezione della fortunata edizione del 2005, affidata a Paolo Bonolis, i primi anni del nuovo millennio vedono Sanremo stazionare, nelle serate più viste, attorno ai 10 milioni di spettatori e appena sotto al 50% di share. Nel 2009 è ancora una volta una conduzione di Bonolis a innescare un nuovo ciclo positivo, che culmina, nell’ultimo triennio, con un ritorno a dati d’ascolto mai così elevati dagli anni Novanta: tra il 2009 e il 2024 sono solo tre le edizioni a non raggiungere gli 11 milioni di AMR – accade nel 2014, nel 2019 e nel 2021, quando, a causa della pandemia, la manifestazione si svolge senza il pubblico in sala – e solo una a non raggiungere il 50% di share nella serata più seguita. In particolare, l’ultimo triennio sembra aver rappresentato un’importante discontinuità nella storia della kermesse: la direzione artistica di Amadeus – cui si affiancano l’esplosione di un fenomeno social come il Fantasanremo e l’incremento dei consumi in streaming tramite RaiPlay – coincide con una nuova centralità della manifestazione, che torna ad essere seguita, in media, da un italiano su 4.
Le serate e le edizioni più seguite
In 25 delle 38 edizioni della manifestazione finora misurate da Auditel la singola serata con ascolto medio più elevato è stata la finale, mentre in 10 occasioni – l’ultima volta è accaduto nel 2014 – l’AMR massimo è stato raggiunto con la serata inaugurale. Un’interessante eccezione a questa tendenza è rappresentata dall’edizione del 1995, che durante la seconda serata del Festival – arricchita, peraltro, dalle esibizioni di Madonna e dei Take That – registrò un ascolto medio di 18.4 milioni di spettatori, risultando (in valori assoluti) la singola serata più seguita dell’intera storia di Sanremo. Nel 2011, invece, la serata più vista fu, inusualmente, la terza: risultò determinante, in questo caso, l’apporto di un ospite come Roberto Benigni, il cui monologo dedicato al Canto degli italiani – in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia – raggiunse un picco di quasi 20 milioni di spettatori e del 66% di share.
Considerando invece le edizioni nel loro complesso, il primato è spartito tra due differenti conduzioni di Pippo Baudo. Nel 1987, infatti, Sanremo registra un dato di share medio tutt’ora insuperato, pari al 68,7%, nell’arco di 4 serate dense di ospiti internazionali – tra i quali figurano, Whitney Houston, Duran Duran e The Smiths – che si esibivano dall’appena inaugurato Palarock; inoltre, rapportando l’ascolto medio alla popolazione dell’epoca, la finale risulta la più seguita di sempre, essendo stata vista da poco meno del 40% degli italiani. Ragionando invece in valori assoluti, sono le 5 serate dell’edizione del 1995 – ricordate anche per la celebre contestazione di Pino Pagano dalla balconata dell’Ariston – a detenere il record dell’ascolto più elevato, con una media di 16.8 milioni di spettatori.
Infine, è ancora una volta un’edizione condotta da Pippo Baudo, quella del 2008, a segnare, invece, il peggior risultato della storia di Sanremo. L’ultimo Festival affidato al presentatore siciliano costituisce, a tutti gli effetti, la chiusura di una fase della storia della TV italiana – tanto da essere superato, durante la terza serata, dalla controprogrammazione di Canale 5, che trasmetteva la seconda stagione de I Cesaroni – e detiene i dati d’ascolto più bassi tanto sulle 5 serate, con una media 6.8 milioni di spettatori e il 36,6% di share, quanto sulla serata più vista, giunta appena al di sopra degli 8 milioni.
Si tratta di un caso unico, finora mai ripetutosi e che se possibile rende ancor più evidente, in ottica di confronto, il grado di pervasività e centralità storicamente detenuto dalla manifestazione nelle abitudini di consumo del Paese. Sebbene, infatti, le comparazioni tra dati d’ascolti riferiti a epoche tra loro distanti presentino non pochi limiti – legati, soprattutto, all’aggiornamento delle metodologie di misurazione – uno sguardo d’insieme alla storia di Sanremo non lascia adito a dubbi: anche a fronte del parziale ridimensionamento della platea televisiva nel periodo post-pandemico, il Festival mantiene saldamente la propria identità di evento mediale nazionale, capace di catalizzare e sincronizzare l’attenzione collettiva come nessun’altra proposta di intrattenimento.