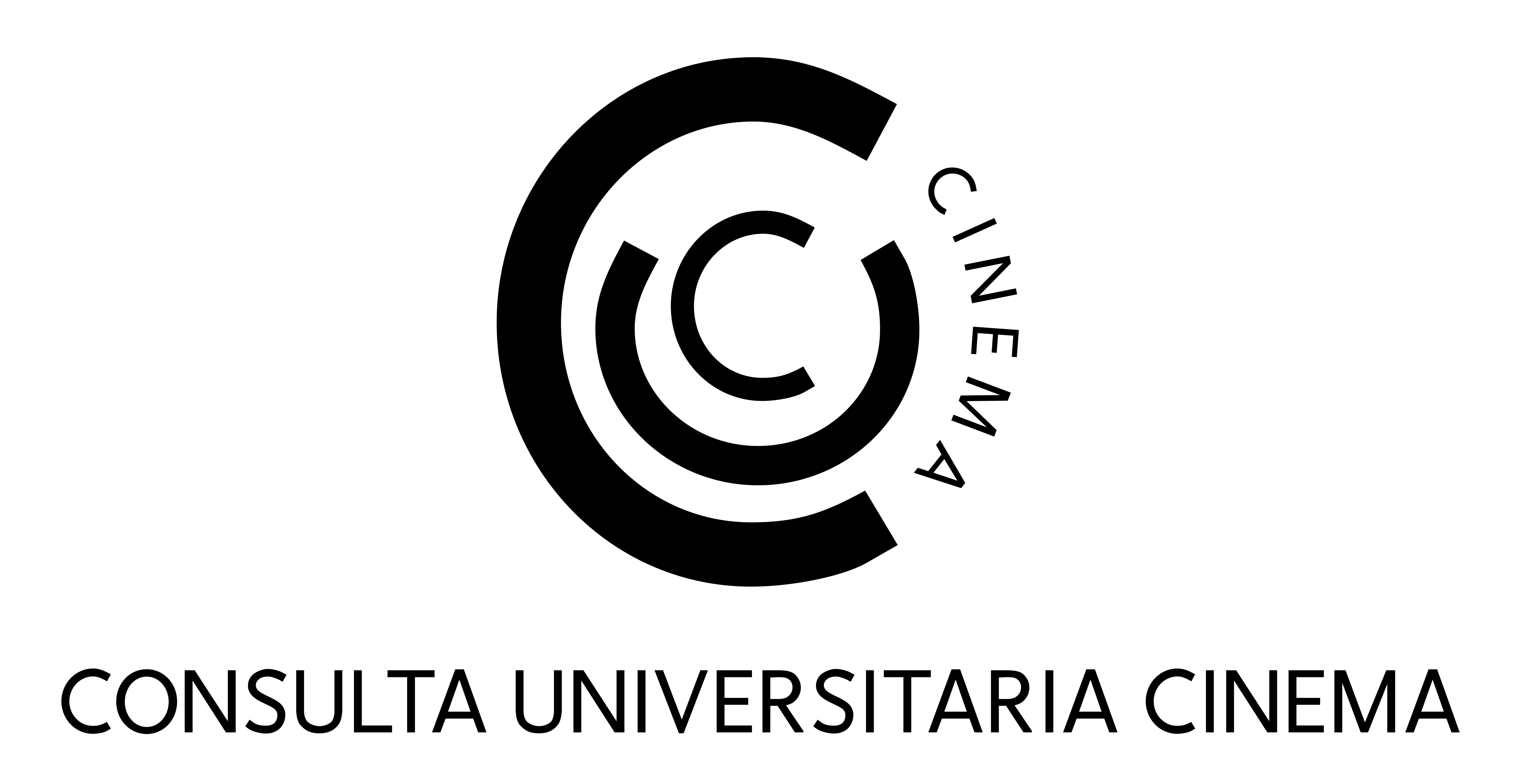Hiroshima mon amour
Ho avuto la mia “folgorazione” cinematografica abbastanza tardi. Frequentavo già l’università con l’intenzione di laurearmi in Storia dell’arte. In quegli anni – la seconda metà dei Settanta – ho visto in televisione a tarda ora – così mi pare di ricordare – il film di un regista di cui non sapevo neppure pronunciare bene il nome: Alain Resnais. Era Hiroshima mon amour. Tre sono le cose che mi hanno letteralmente travolto: l’immagine-tempo, come avrebbe detto in anni successivi Deleuze, ossia un’immagine vertiginosa che abbatte le abituali coordinate cronologiche, intrecciando il pensiero, la memoria e l’esperienza, ciò che sta fuori e ciò che sta dentro di noi, ciò che è vicino e ciò che è lontano; il palpito dei corpi ripresi dalla macchina da presa, quella loro fisicità stilizzata che emanava vita e arte insieme; l’incanto delle voci dialogiche, “composte” da Marguerite Duras, che si intrecciavano, si sconfessavano, si ripetevano, si scindevano, sospese nel trauma dell’amore e della morte, del ricordo e dell’oblio, del reale e dell’immaginario, sempre vaganti nel cortocircuito di una danza letteraria ed esistenziale. Probabilmente il trauma era per me una delle fonti più grandi di attrazione perché, non a caso, il secondo film che ha acceso il desiderio di occuparmi di cinema è stato Germania anno zero di Roberto Rossellini, proiettato nella sala della Facoltà di Lettere di Siena. Seguivo il corso sul neorealismo tenuto da Lino Micciché, il professore che ha ispirato e suggellato il mio incantamento verso quell’arte “settimina” a cui non avrei mai immaginato prima di dedicare le mie passioni e le mie ricerche.
0