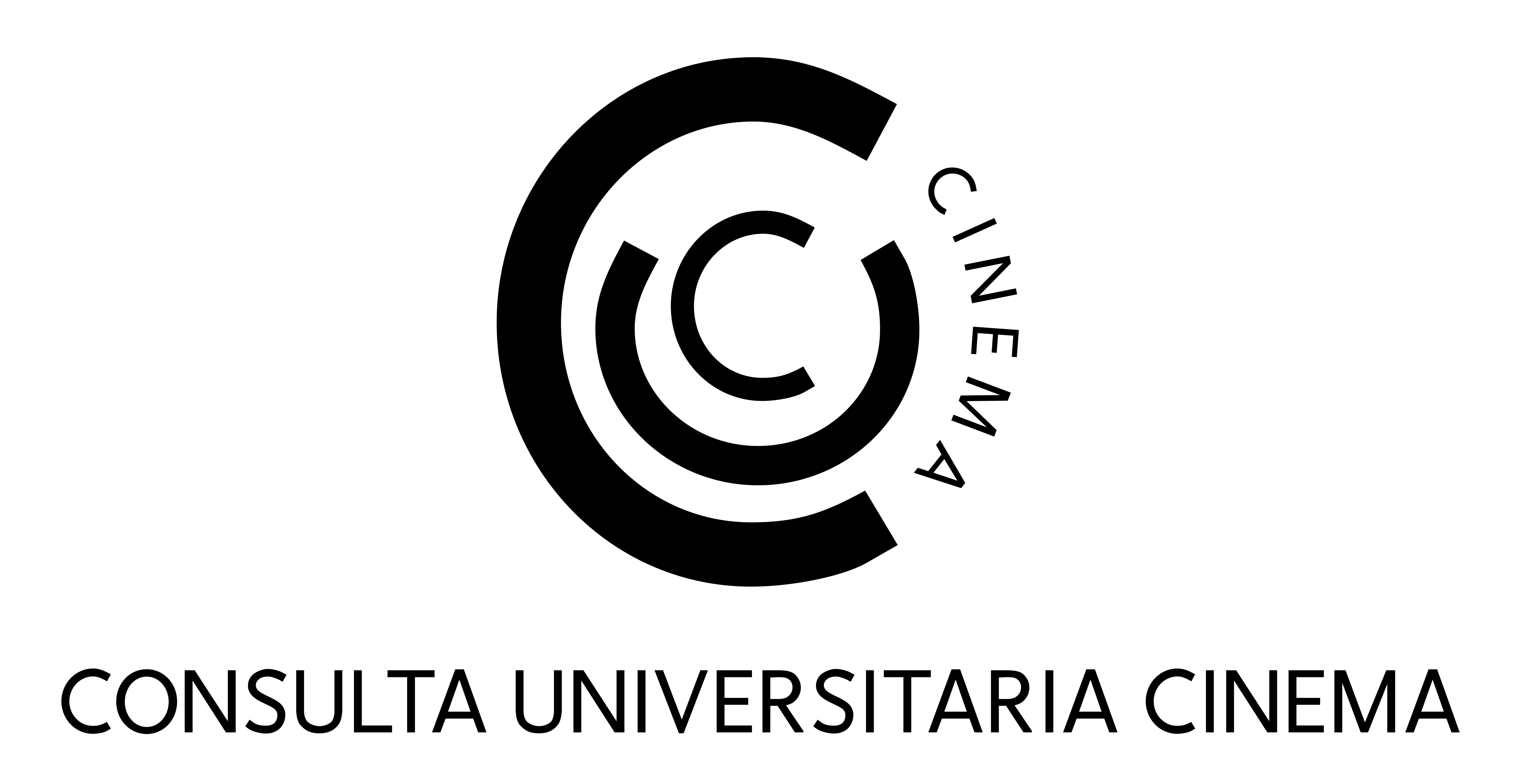La febbre dell’oro
Charlie Chaplin, La febbre dell’oro. Ricordo l’incanto dei primi minuti. I paesaggi avventurosi, la camminata sghemba del Vagabondo seguito dall’orso, la baracca scossa dal vento e dalla neve, il gelo del Klondike – che niente aveva a che fare con la placida sera in cui io bambino fissavo lo schermo di un’arena estiva. Pochi minuti e la magia è compiuta, la piazza avvinta dal film, percorsa da risate elettriche. Chaplin improvvisa una misera cena e gioca con noi: porta in tavola lo scarpone bollito, arrotola i lacci come fossero spaghetti, lo spina e ripartisce le porzioni – la suola e la tomaia. Big Jim gli ruba la parte più polposa. Il cenno sul viso del Vagabondo, che rotea gli occhi e solleva le labbra per dirci “facciamo finta che sia buono”, condensa in un istante la fame e la sopraffazione. Ecco la promessa del cinema: in quello scarpone (di liquirizia, scoprii più tardi) tramutato in cena da uno sguardo che invita a soffrire e ridere assieme.