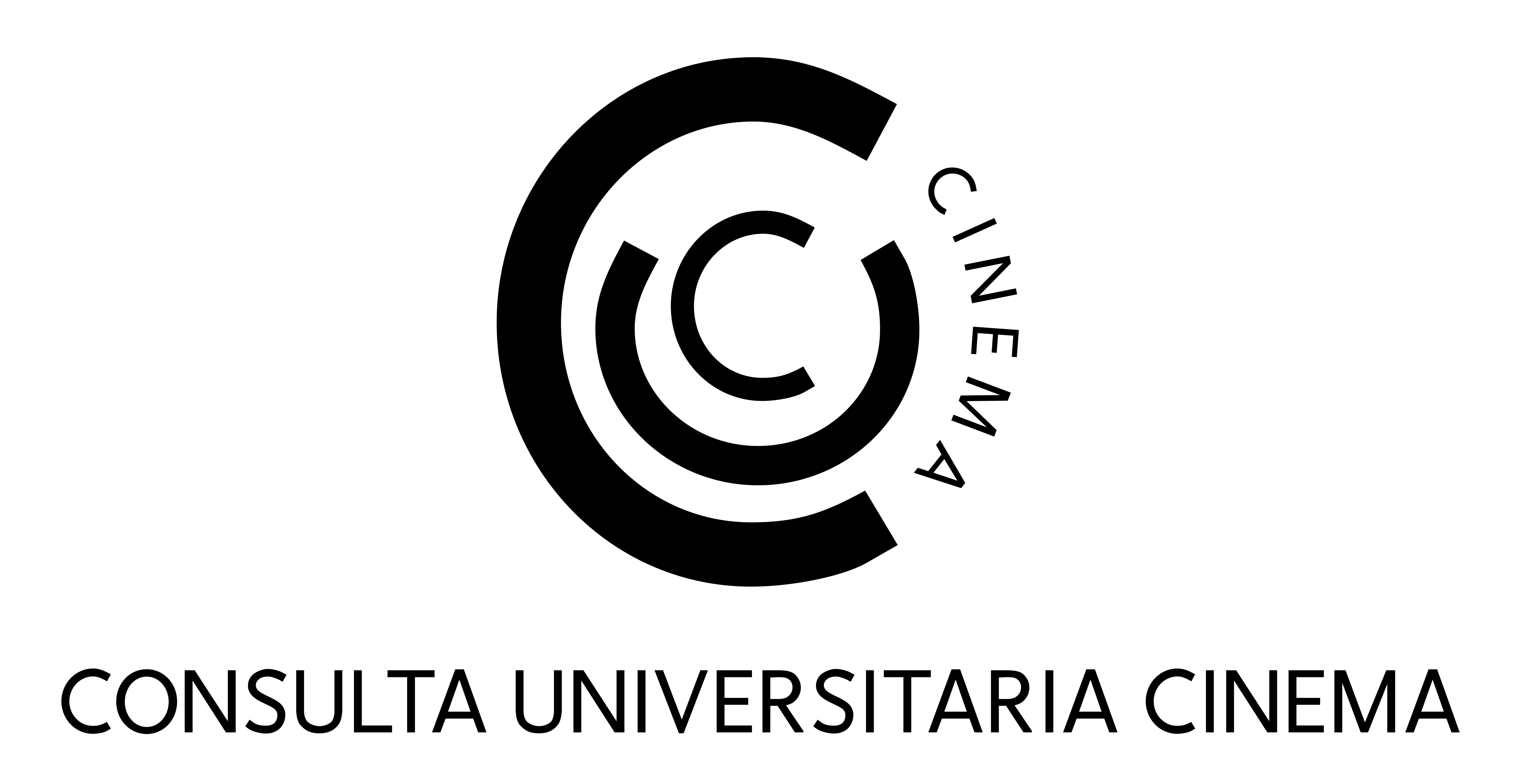Il cavallo di Torino
Davanti a una finestra affacciata sulla campagna scossa da un vento impetuoso, una donna siede in silenzio a fissare il paesaggio immutabile e svincolato dal flusso del tempo. La finestra è una duplicazione dello schermo cinematografico destrutturato e svuotato di immagini; è metafora di una quotidianità che scorre sempre uguale a sé stessa, ripetizione en abyme di azioni che solo il cambio di angolazione della macchina da presa riesce a movimentare. E fuori dalla casa di pietra c’è un’unica certezza: il vento, presenza inesorabile che accompagna l’esistenza di padre, figlia e del loro cavallo. Il numero tre ha una forte simbologia religiosa: il terzo giorno Dio separò la terra dalle acque e ordinò che la terra producesse frutti; il terzo giorno Cristo resuscitò. Ne Il cavallo di Torino, invece, il terzo giorno segna l’apice parossistico di un’esistenza ormai inutile. Nei giorni seguenti, il mondo inizia a sgretolarsi: gli elementi a poco a poco svaniscono, il vento cessa e rimane solo l’attesa della fine. È una genesi alla rovescia quella raccontata da Béla Tarr, un creato che torna nelle tenebre che precedono il verbo divino. Tarr approda a un pessimismo cosmico che non risparmia nessuno, imprigionando il nostro sguardo in un buio ineluttabile.