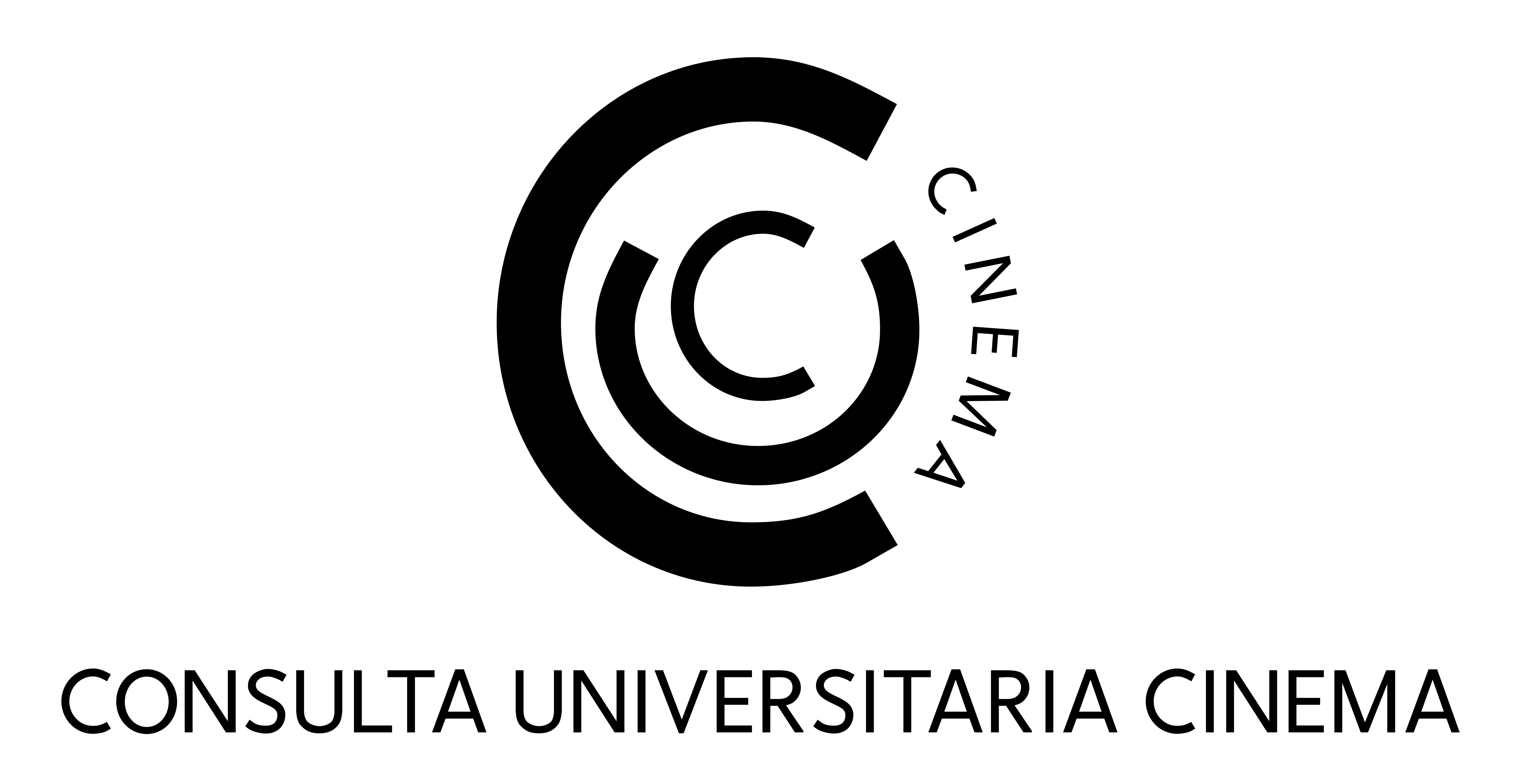Amarcord
Ricordo la prima volta che non ho visto Amarcord. Nel 1979, al cineclub del mio paese. Non ero stato ammesso: non era film adatto a un bambino di sei anni. Nei giorni successivi i partecipanti se ne raccontavano scene e battute che assorbivo mentre ascoltavo il vinile della RCA. Sulle musiche appoggiavo un film immaginario, mescolando i frammenti dei racconti e i fotogrammi in copertina. Tanto acuta questa assenza, da cancellare la prima visione: non so quando ho visto la prima volta Amarcord, ma da allora l’ho visto decine di volte. Al punto da impararne a memoria scene, dialoghi e movimenti di macchina, e da descriverli a voce alta, tra l’imbarazzo dei presenti, quando passava su qualche schermo. Nel frattempo, visione dopo visione, il film cambiava. Quella che mi era sembrata una reverie colorata diventava la terribile raffigurazione dell’eterno fascismo italiano. Dietro l’elegia spuntava la caricatura; dietro il poeta l’antropologo; dietro il sogno, l’incubo a occhi aperti.