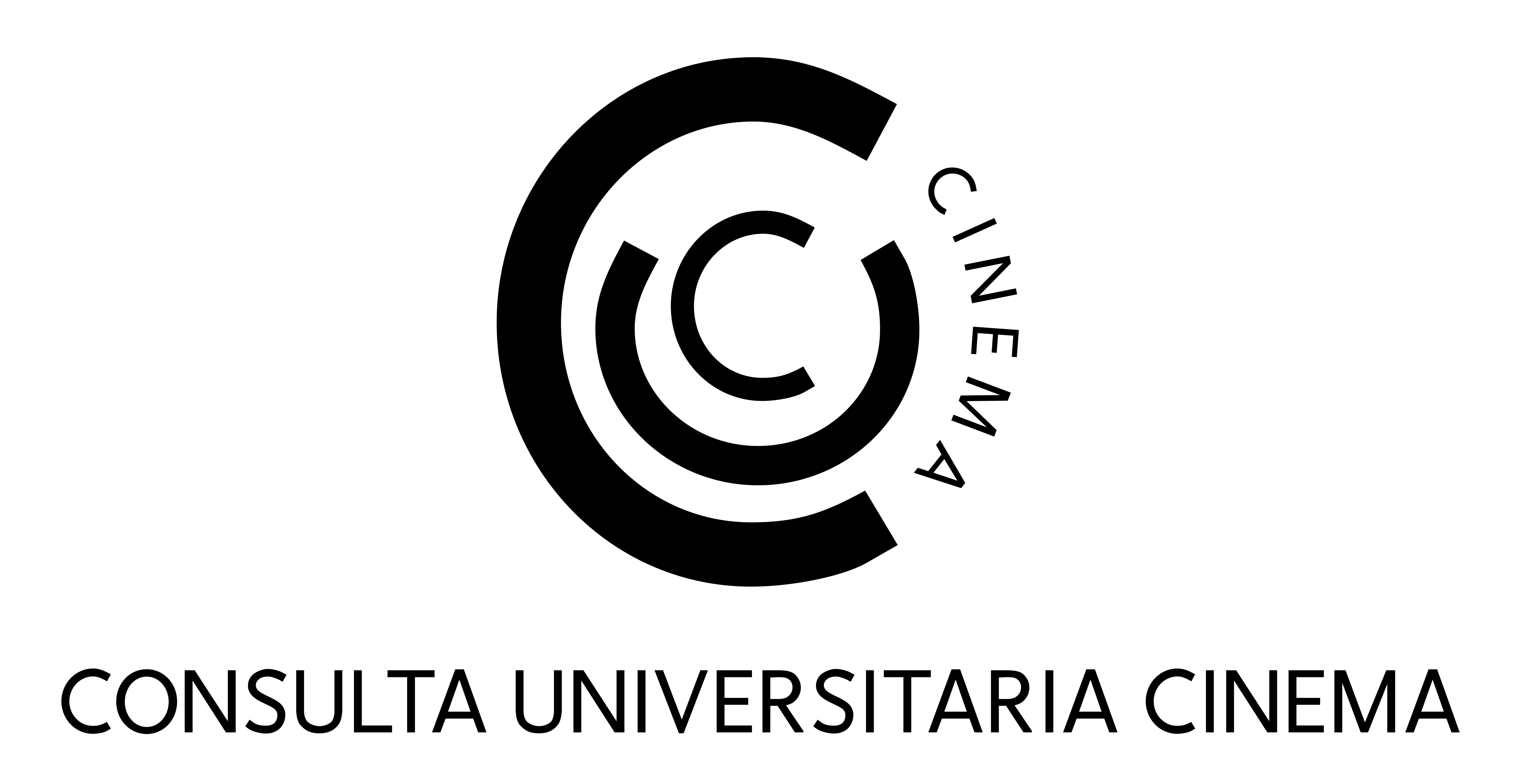Rosemary’s baby
Lo vidi in TV. Non ricordo l’anno esatto, ma di certo non avevo ancora sedici anni. Non sapevo che, molti anni dopo, avrei dedicato una tesi di laurea a Roman Polanski. Sapevo solo che quella sera avevo voglia di avere paura e spegnere pensieri che mi sembravano enormi. Sono passati più di trent’anni ma, se chiudo gli occhi, rivivo facilmente l’impressione che mi fecero le note distorte di Komeda e le grida di terrore di Mia Farrow, doppiata da una voce forse ancora più animalesca della sua. Ma quello che più mi colpì era la luccicanza dei volti, dei corpi, delle superfici. Rosemary’s baby era (ed è) un film senza buio, un incubo senza spazi neri. Non capivo perché, ma questa cosa mi affascinò moltissimo. Dieci anni dopo ho capito: Polanski aveva utilizzato un flashed film, per dare all’immagine una consistenza indistinta ma allo stesso tempo vivida. Non so se Rosemary’s Baby è il film della mia vita. Di certo è il film che ha mosso in me la voglia di sapere cosa si nasconde dietro un’inquadratura, dietro la scrittura di un personaggio, negli spazi al contempo luminosi e oscuri di questo straordinario linguaggio.