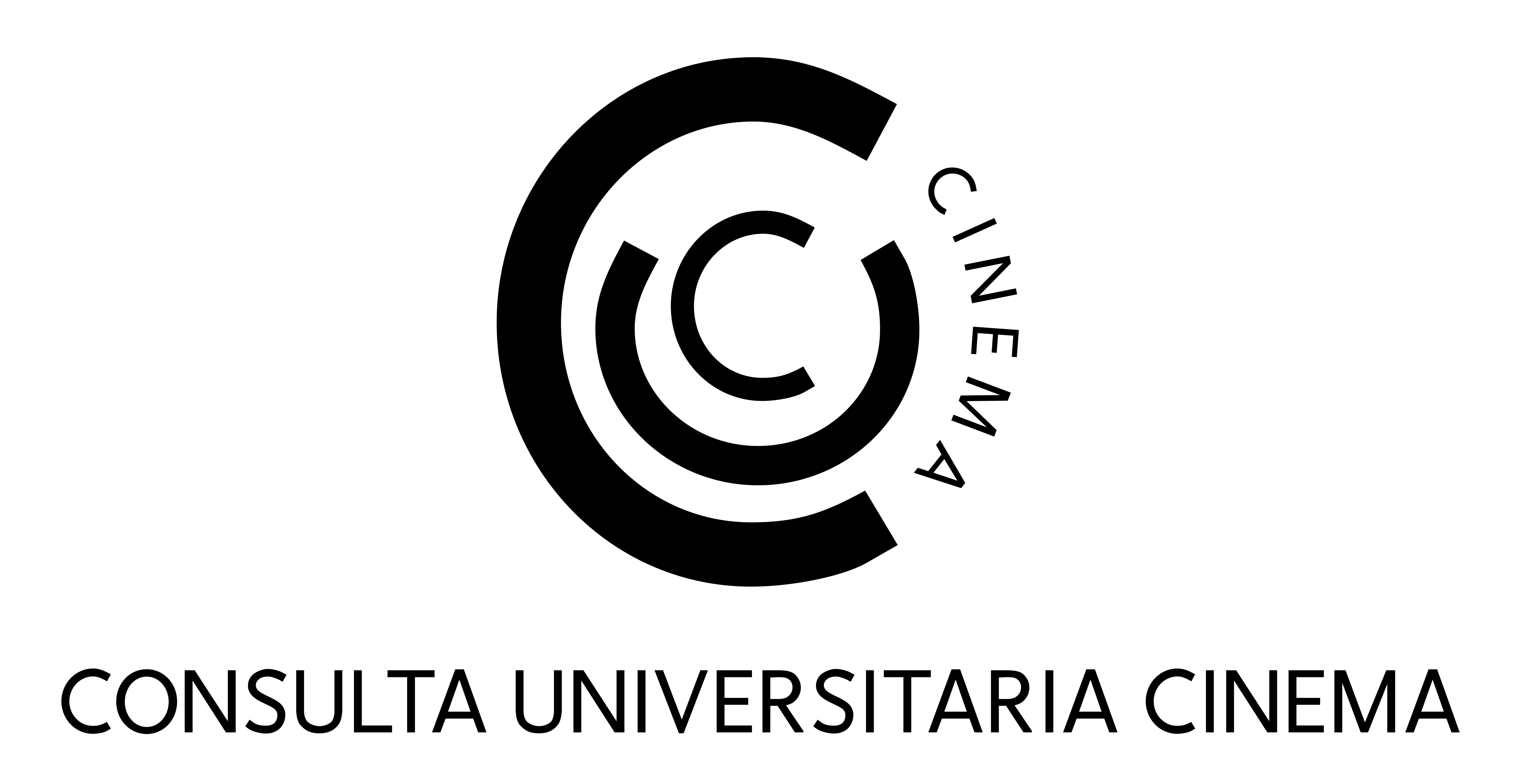Sanremo e i cantautori: quel bisogno di autenticità che abbiamo tutti…
È un vecchio tormentone che si ripete anche quest’anno: ci sono, non ci sono, lo amano, non lo amano… i cantautori e il Festival, una relazione mai risolta veramente. Sappiamo bene che il cantautorato nasce storicamente in diretta opposizione alla grande macchina del mainstream rappresentata da Sanremo: si delinea come modo di produzione secondo una logica che in determinati momenti, in particolare dopo il Sessantotto, mira a essere esplicitamente contro-culturale. Delinea un percorso alternativo e contestatore, fino a erigere nella stessa “città dei fiori” un monumento della critica al sistema delle canzonette come il premio Tenco. Chi in quegli anni getta il cuore oltre l’ostacolo, gioca col fuoco: come Lucio Dalla, quasi bruciato tanto dal successo di 4 marzo 1943 nel 1971 (terza classificata), quanto dall’insuccesso di Piazza grande nel 1972 (ottava)[1]. Ma l’attrazione tra i due poli non è mai mancata, e già dal 1982 il Premio della critica permette di rimarcare e reiterare il gioco fecondo e dialettico della canzone d’autore con il prodotto mainstream (che rimane ovviamente il cuore dell’impresa).
Se chiedo all’Intelligenza artificiale perché i cantautori vadano a Sanremo, mi risponde che i cantautori partecipano per diverse ragioni: per raggiungere un pubblico più vasto, affermare a livello popolare la propria visione artistica, lanciare un messaggio importante o semplicemente rilanciare la propria carriera. Nonostante il Festival abbia spesso un’anima legata al pop più commerciale, mi ricorda lo stesso ChatGPT (e chi meglio ne può sapere di anima commerciale), i cantautori hanno saputo utilizzare questo spazio per arricchire il panorama musicale italiano, portando profondità, autenticità e poesia. Un posto d’onore lo riserva a Un’avventura di Battisti, 1969, perché, pur rispettando formalmente i canoni melodici dell’epoca, introduceva un’energia soul e un linguaggio musicale fresco e moderno. Ed è vero che nella sua unica partecipazione da interprete al Festival, il nostro si presentò in coppia con un’icona R&B come Wilson Pickett (la canzone arrivò nona). Difficile negare questo buon senso comune che l’AI raccoglie così efficacemente: da Lucio Battisti sono stati influenzati autori che negli anni successivi hanno elaborato un cantautorato emozionale, senza la necessità dell’impegno esplicito e pure legati al proprio gesto creativo. Al limite con una buona dosa di provocazione, come nell’esordio cult di Vasco Rossi (Vado al massimo, quarto nel 1982 in una classifica parificata dopo il podio). Anche un cantautore più classico e intellettuale come Roberto Vecchioni, quando negli anni della saggezza si è presentato sul grande palco festivaliero con il ramoscello di ulivo, – era Chiamami ancora amore, prima classificata nel 2011 – ha costruito la denuncia amara come sfondo ampio e generico (i “signori del dolore”), e portato in primo piano piuttosto i toni caldi ed esistenziali, scegliendo peraltro per l’occasione un linguaggio per lui inusualmente colloquiale, fino all’anafora e all’anacoluto.
Ora, invece di fermarci al giudizio sulle qualità di scrittura musicale o poetica, per quanto legittimo, più prosaicamente dobbiamo da un lato considerare il Festival di Sanremo per quella grande macchina mediatica che conosciamo, tra radio, televisione e social, e dall’altro la stessa industria della musica pop come una filiera del sistema dei media. La canzone, leggera, anzi leggerissima, immediatamente cantabile, appare allora in tutta la sua portata di medium per eccellenza, come una forma matrice dei consumi del contemporaneo: Peppino Ortoleva vi riconosce uno degli elementi costitutivi della circolazione di dati in rete, alla pari di un meme o di una news[2], mentre Gianni Sibilla la paragona a un software, per il suo costante aggiornamento in nuove versioni[3]. Proprio perché ondivaga, alla canzone serve un gancio identitario forte da trovare in un performer o in un autore. Il cantautore tecnicamente offre entrambe le dimensioni. Certo, a Sanremo non performa l’uomo-con-la-chitarra del Folkstudio. È richiesto un compromesso, che nel migliore dei casi è una timbrica marcatamente individuale e immediatamente riconoscibile, come la voce graffiante di Carmen Consoli, eliminata ma applaudita nel 1997 con Confusa e felice, poi un suo pezzo-bandiera. E negli altri richiede attitudine ludica, come nelle partecipazioni di Colapesce e Dimartino, che si tuffano a terra per mimare lo Splash della loro canzone omonima (decima classificata nel 2023). O coreutica: il duetto di Daniele Silvestri con il ballerino Fabio Ferri per Salirò (quattordicesima classificata nel 2002) è un passaggio decisivo nell’integrazione della danza nelle performance dei cantanti sul palco dell’Ariston. Ma sempre l’aura cantautoriale garantisce alla performance il brivido della libertà dalle costrizioni. Silvestri arriva sesto quando presenta un pezzo grintoso e politico come A bocca chiusa (2013). Meglio di qualunque altra figura del mondo dello spettacolo, il cantautorato dà soddisfazione alla legge del talent di kantiana memoria: l’opera d’arte da un lato necessita di una regola, dall’altra della libertà da ogni interesse. Una contraddizione di fondo che si supera nel “genio”, ovvero nel “talento che dà la regola all’arte”, perché possiede intimamente la regola (la competenza) e la esprime naturalmente (nella condizione ideale di chi è libero da spinte e pressioni ideologiche o commerciali)[4].
Lo schema performance & creazione soddisfa insomma il bisogno di autenticità che la fabbrica di sogni e paillette sanremese tendenzialmente da sola non riesce a coprire. Ma nel contesto mediale l’impronta orale della performance musicale, portatrice di un’immediata risonanza nell’ascoltatore, va riportata a un livello ulteriore e finale. Il senso di autenticità si riferisce infatti più all’intensità o alla coerenza dell’esperienza di ascolto, che all’attestazione a un ipotetico grado di verità o “presenza”. Con Philip Ausländer, riconosciamo il rapporto paradossale di complementarità tra spettacolo mediale ed esibizioni dal vivo: se l’autenticità della registrazione deriva da una sensazione intuitiva o simbolica della sua origine live, l’autenticità della performance risiede nella sua relazione con il sistema tecnologico[5]. Semplificando e forse banalizzando un poco: in un panorama di consumo musicale sempre più frammentato, algoritmico e impersonale, quando anche il cantautorato si riduce a un progetto inscritto in un tag (quest’anno: Irama, Rkomi), nei casi di più marcata autoironia in un logo aziendale (Brunori Sas), è la stessa Sanremo, l’ultimo grande evento mediale collettivo non sportivo, che attesta infine l’esistenza dell’autore. A costo di dover duettare con Topo gigio (Lucio Corsi, serata delle cover 2025).
[1] Sul ruolo di Sanremo nella carriera e nell’iconografia di Dalla, cfr. L. Spaziante, Lucio Dalla, per brevità chiamato cantautore, “Comunicazioni sociali”, 3-2022, pp. 315-330.
[2] P. Ortoleva, Il secolo dei media. Stili, dinamiche, paradossi, Milano, il Saggiatore, 2022², pp. 317-329.
[3] G. Sibilla, L’industria della canzone, Bari-Roma, Laterza, 2024, pp. 21-27.
[4] I. Kant, Critica della facoltà di giudizio (1790), Einaudi, Torino 1999, p. 143.
[5] P. Ausländer, Liveness. Performance in a Mediatized Culture, Third Edition, Routledge, Abington-New York 2023, p. 7.