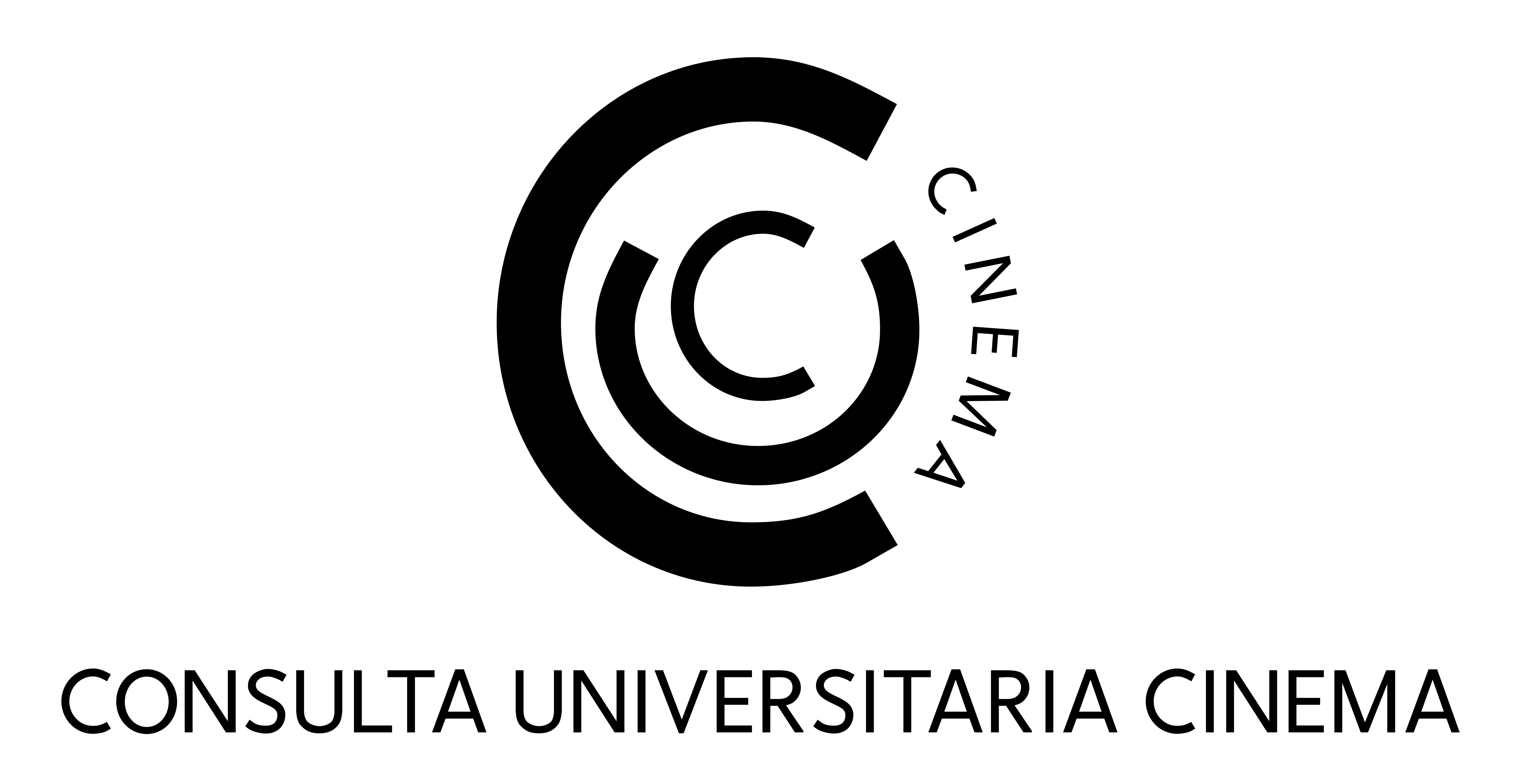Vive l’amour
Il rumore dei tacchi di Mei-Mei sull’asfalto, la terra rivoltata di un parco ancora privo di erba, i palazzi di una Taipei quasi deserta sullo sfondo. Poi la macchina da presa che si stacca dalla protagonista, perdendola di vista, per tracciare il suo percorso in una città stritolata da una modernità contradditoria. E il primo piano quasi insostenibile sul pianto disperato della protagonista. Nella lunga sequenza finale di Vive l’amour c’è, sin dal giorno in cui l’ho vista per la prima volta, qualcosa che non finisce mai di commuovermi. Forse è la capacità di mostrare il senso di solitudine che attraversa gli amori impossibili, forse la distanza incolmabile che separa Mei-Mei dall’unica forma di vita che incontra nel suo girovagare, un anziano la cui indifferenza rende la scena ancor più glaciale. Quale che sia il motivo, è con qui che ho sentito, forse per la prima volta, la potenza di un cinema così vero e bello da far male a chi lo guarda.
0
0