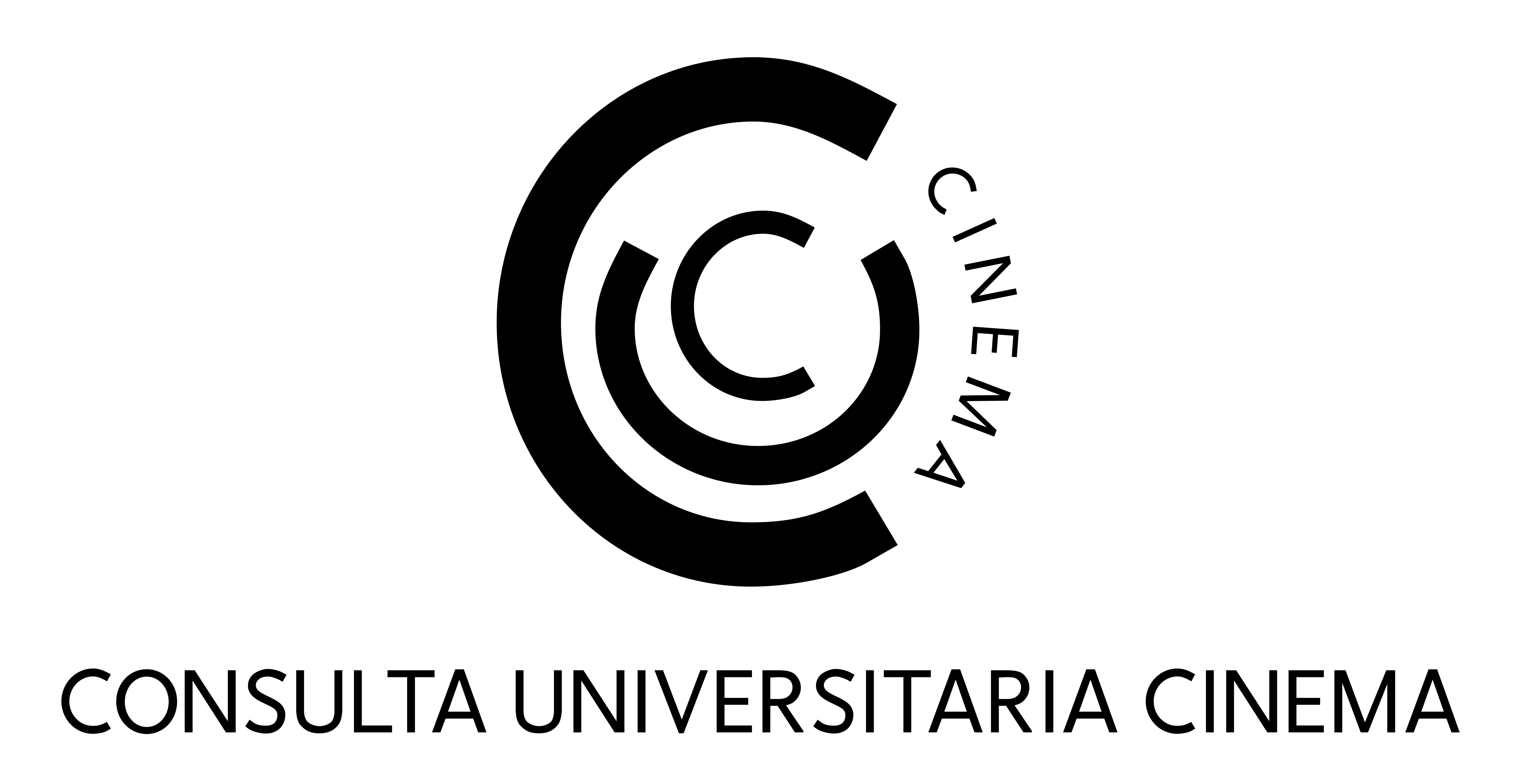Terminator
Undici anni. Cinema all’aperto. Ricordo una visione con i muscoli contratti dalla tensione (quel mostro che non muore mai, lo scheletro metallico dalla camminata precaria e implacabile). Ricordo anche di aver provato una specie di eccitante disgusto (la scena dell’occhio nel lavandino, che non la vuoi vedere e allo stesso tempo non ne puoi fare a meno). Ma soprattutto ricordo il dopo. Camminando con la mia famiglia nella baraonda estiva di luci e gelati, sentivo che il film non aveva abbandonato il mio corpo, che io stessa ero rimasta dentro la storia: ero Sarah, ero il Terminator (mi ero messa gli occhiali da sole, di notte), ero bambina, adulta, femmina, maschio, umana, macchina, reale, finzione. Allora non lo sapevo, ma più tardi avrei concettualizzato quella prima Sindrome di Stendhal (avrei scoperto le complicazioni dell’identificazione, i body genres, le fluttuazioni delle identità). All’epoca, semplicemente mi lasciavo sconquassare da quella vertigine di smarrimento e potere.