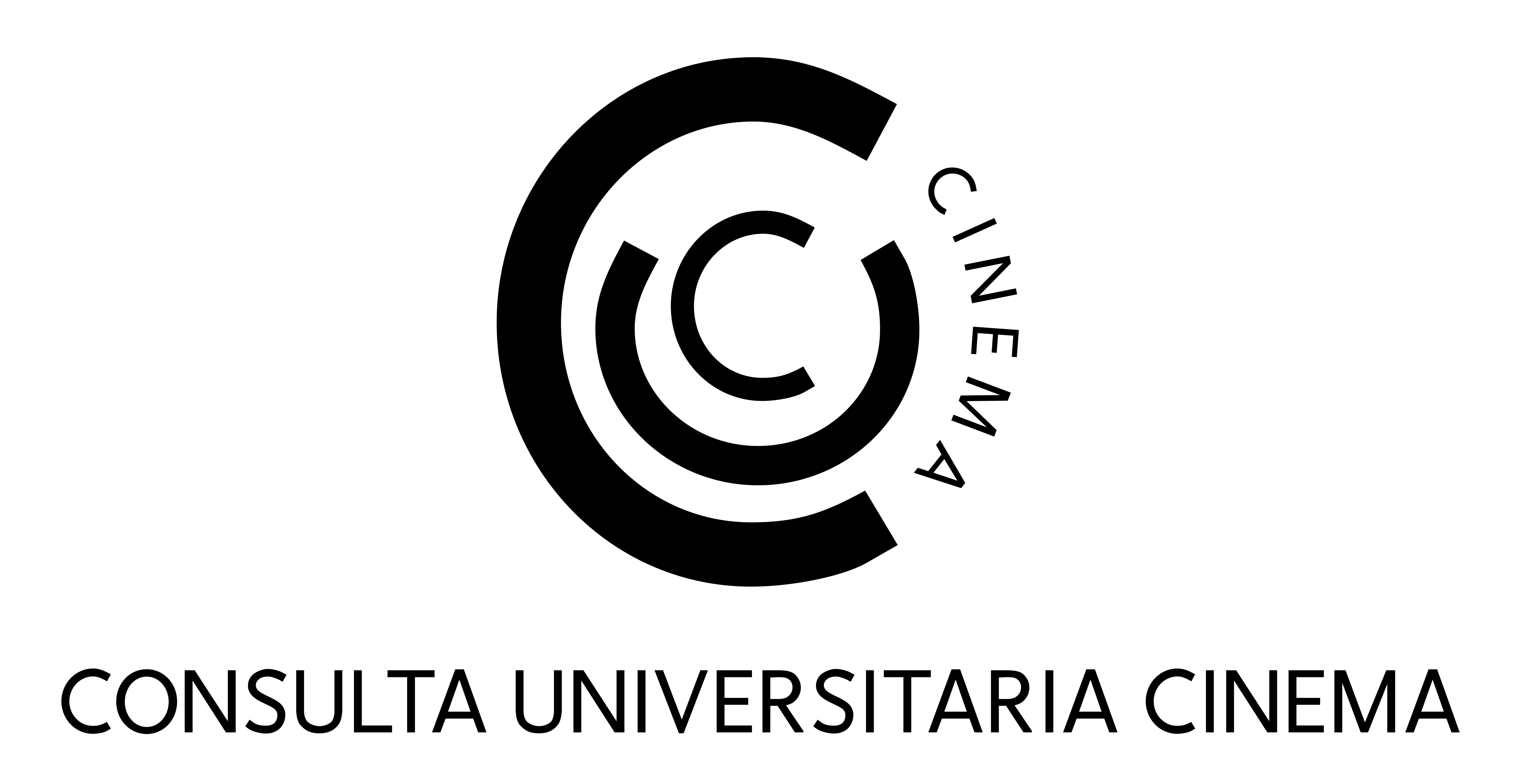Morte a Venezia
Nel buio della città, putrescente e fantasmatica, Gustav von Aschenbach adesso barcolla. Persino la rosa appuntata all’occhiello della sua giacca – bianca e sgualcita come la calce a imbrattare le strade – ha preso l’aspetto di un vezzo ridicolo e di un ossimoro indegno. Così, mentre l’illustre Maestro si affloscia contro un pozzo, tra i cumuli di foglie marcite e i rifiuti del giorno, mentre la sua figura si annulla ansimante nello sguardo di un uomo, che scuote la testa disgustato o indifferente, in un tratto, il suo volto si deforma scomposto. È un ghigno grottesco e un pianto senza speranza, ma che sparisce rapido nella cacofonia reboante di un’orchestra. Nel pomeriggio tardo di un inizio di giugno, in un breve frammento di Morte a Venezia, Luchino Visconti sembrò rivelare il dramma feroce e impudicamente ridicolo del perdere sé stessi.