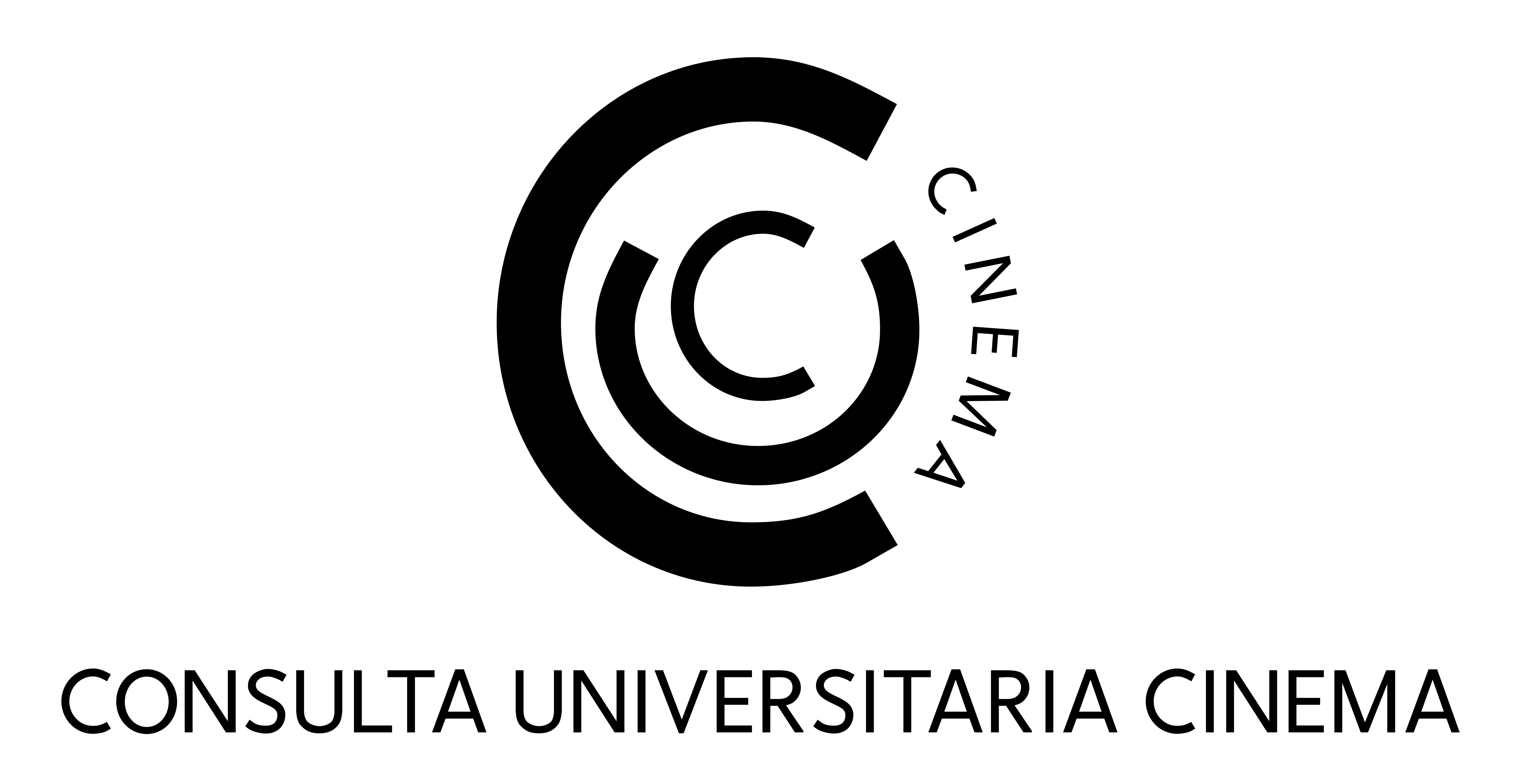Electric Earth
48a Biennale di Venezia. 1999. Corderie. Dark room. Otto schermi su cui si alternano, a volte speculari, a volte fornendo punti di vista diversi, le sequenze dello stesso film. Un giovane afroamericano. Catatonico, sul letto, il telecomando in mano puntato su un televisore di cui non è visibile lo schermo, solo la luminosità. La sua voce fuori campo: “A lot of times I dance so fast that I become what’s around me […] It’s like I absorb that information. It’s like I eat it”. Attraversa spazi metropolitani desolati. Marciapiedi. Una telecamera di sorveglianza. Los Angeles. Movimenti spasmodici, a tratti funk, a tratti convulsioni. Rituale, tribale, integrato e dislocato al contempo. Liquor store e lavanderie a gettoni, illuminati al neon. Trofei dorati in vetrina. Stiramenti. Contrazioni. Contorsioni. Un carrello lanciato nel parcheggio vuoto di un supermercato. Il ritmo di una drum machine sempre più veloce: trasposizione dei rumori della città, di cui il corpo si fa vettore. Conosco quel ritmo. Conosco quelle sinestesie. Sarà perché Doug Aitken ha già realizzato numerosi videoclip, su tutti quelli per Fatboy Slim. Electric Earth usa gli stessi codici ma offre un’esperienza immersiva. Ho 20 anni. Sento lo spirito del mio tempo: la città che diventa corpo, il corpo che diventa immagine e l’immagine che diventa energia elettrica. E di quell’energia divento anche io vettore. Impossibile tornare indietro.
0